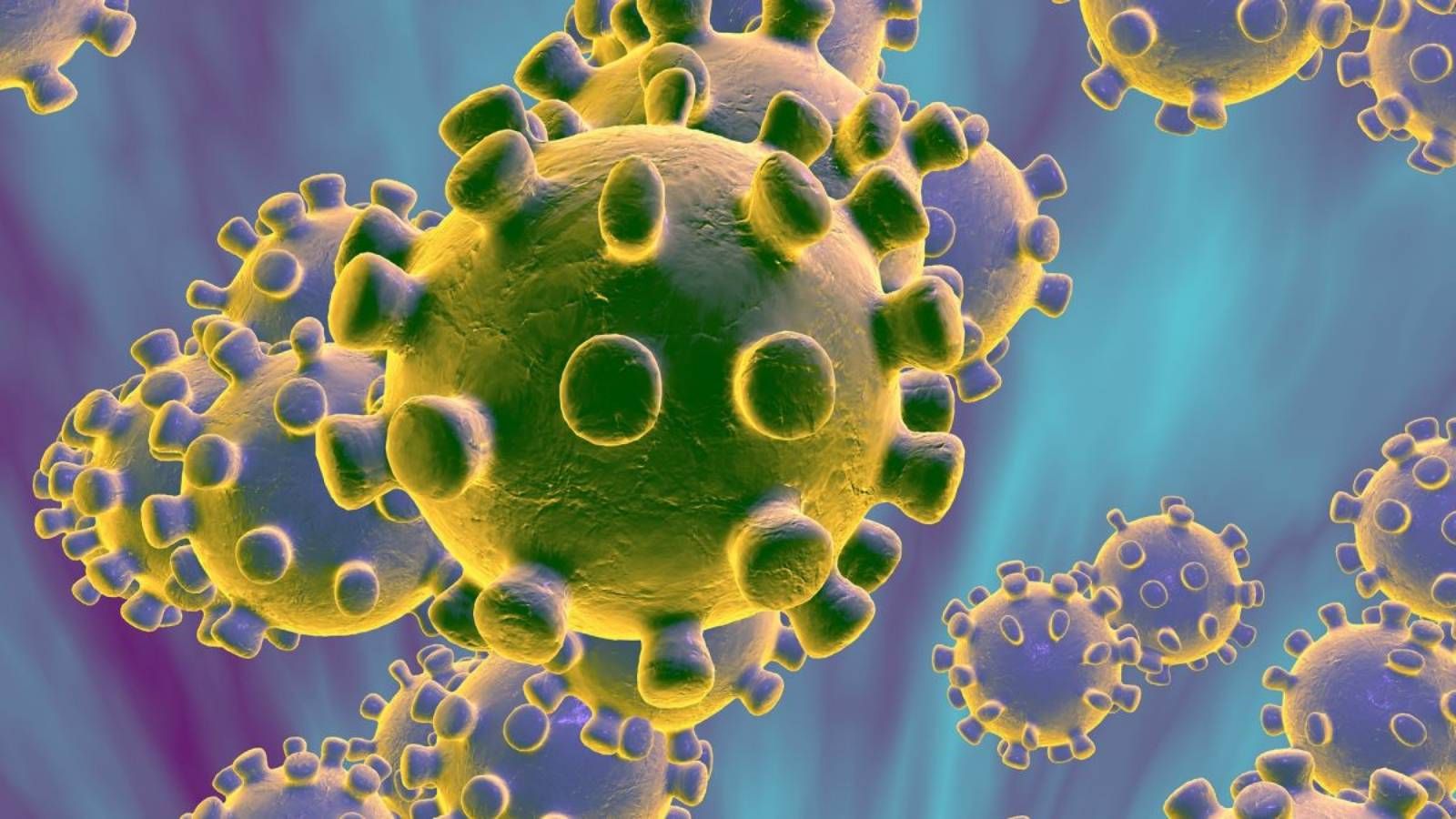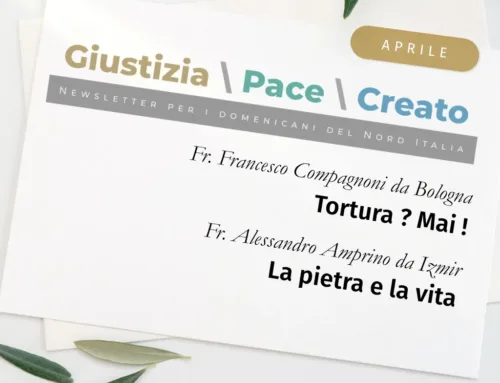«La parola “peste” era stata pronunciata per la prima volta. […] I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. Il dottor Rieux era impreparato, come lo erano i nostri concittadini, e in tal modo vanno intese le sue esitazioni. In tal modo va inteso anche com’egli sia stato diviso tra l’inquietudine e la speranza. Quando scoppia una guerra, la gente dice: “Non durerà, è cosa troppo stupida”. E non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non le impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre, ce ne s’accorgerebbe se non si pensasse sempre a se stessi. I nostri concittadini, al riguardo, erano come tutti quanti, pensavano a se stessi». Si tratta di un passaggio de La peste di Albert Camus. Pubblicato nel 1947, il romanzo dello scrittore ed intellettuale engagé – premiato dieci anni dopo col Nobel per la Letteratura – presenta certamente una scabra metafora dell’occupazione nazista e, più ampiamente, del male sperimentato dall’umanità, ma in questi giorni molto singolari segnati dal diffondersi del Covid-19 può essere riletto anche “semplicemente” per il suo senso letterale, per la capacità di evocare le molteplici risonanze del contagio. Rileggere Camus nell’epoca della globalizzazione tecnocratica, lungi dal risultare un’operazione inattuale, può infatti aiutarci ad attraversare – mentalmente indenni – il chiacchiericcio dei populisti e le paranoiche ricostruzioni dei complottisti, le code per approvvigionarsi di acqua e viveri e le proteste per il rinvio delle partite di calcio. Confrontarsi con la sapiente narrazione di un’epidemia molto più straziante e letale, dialogare con i diversi personaggi misurandosi con pensieri, sentimenti ed azioni sorti nella sofferta solitudine dell’isolamento di Orano, decifrare l’umanesimo integrale e solidale del dottor Rieux o gli affondi teologici delle omelie di padre Paneloux S.J., sono solo alcuni degli esercizi di pensiero che la lettura de La peste ci consente di compiere per tentare d’imparare qualcosa da quest’epidemia di coronavirus. A mio parere, ci sono due temi che emergono tra gli altri da quest’inaspettata esperienza e non mi riferisco – come qualche lettore potrebbe a ragione immaginare – alla classica questione di pertinenza della teodicea si Deus sit, unde malum? (se Dio esiste, da dove il male?) o al senso della sofferta scelta di non ammettere i fedeli alle celebrazioni eucaristiche. [A mo’ di nota a margine, spero che quest’ultima situazione abbia costretto non pochi cattolici praticanti ad interrogarsi su che cosa significa essere Chiesa in una società secolarizzata, in cui lo stato laico in casi eccezionali può chiedere alle autorità religiose di limitare la partecipazione al culto divino per tutelare la salute pubblica e la sostenibilità delle strutture sanitarie. Un caso serio, certamente, che ha portato alcuni a disobbedire, altri a protestare o a criticare le decisioni dei vescovi, ma che – in ogni caso, con buona pace dei più intransigenti – non ha assolutamente a che vedere con qualsiasi presunta forma di svalutazione della santa Messa!]. Chiusa la parentesi, il primo tema che intendo prendere in considerazione rispetto all’attuale epidemia riguarda la rinnovata consapevolezza dell’innegabile vulnerabilità umana. Che a fronte del progresso medico, economico e tecnologico dell’Occidente la coscienza di questa fondamentale caratteristica umana si sia indebolita può essere facilmente rilevato a livello sociologico, al punto che – al di là delle singole vicende biografiche – vi è chi ha pensato di inquadrare la morte come mero “problema tecnico” da risolvere nel futuro prossimo attraverso gli sviluppi delle biotecnologie e dell’ingegneria biomedica. Mi riferisco all’acclamato Homo Deus. Breve storia del futuro di Yuval Noah Harari, storico della Hebrew University di Gerusalemme, che procede dalla descrizione del controllo conquistato dall’umanità sulle calamità naturali, sulle epidemie e sulle guerre: «All’inizio del XXI secolo è più probabile che l’umano medio muoia per un’abbuffata da McDonald’s piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di al-Qaida. […] nella lotta contro calamità naturali come aids ed Ebola i rapporti di forza si stanno sbilanciando a favore dell’umanità. […] È finita l’epoca in cui osservavamo atterriti e indifesi l’infuriare delle epidemie sul pianeta». Non è ovviamente sufficiente limitarsi a costatare quanto surreale appaia oggi quest’affermazione; occorre invece riscoprire il senso della nostra vulnerabilità in modo da orientare le ricerche scientifiche non nella direzione irrealistici progetti di potenziamento, quanto piuttosto verso la prevenzione e la cura di ogni essere umano. Ma la riconquista del senso della vulnerabilità da sola non basta, occorre anche – ed è il secondo tema – comprendere che l’attuale epidemia ci ricorda quanto sia ancora più illusoria la pretesa di poter vivere ripiegati su se stessi, secondo il diktat della non inferiore pandemia d’individualismo narcisistico. Benché possa preludere ad una recrudescenza egoistica, il coronavirus ci ricorda che non siamo individui assoluti, cioè sciolti-da-legami, ma persone-in-relazione al punto che – proprio in forza del corpo e del suo radicamento nella natura-ambiente – siamo tutti collegati, dalla Cina alla bassa lombarda. Solo se pensata insieme alla relazionalità intrinseca del genere umano, la consapevolezza della vulnerabilità che non cede alla paura può rigenerare quella cultura della solidarietà che, anche se impersonata da non-credenti come il dottor Rieux, costituisce un’efficace praeparatio evangelica.
fra Marco Salvioli(“Nostro Tempo” 8 marzo 2020)
[/fusion_text][/one_full]]]>