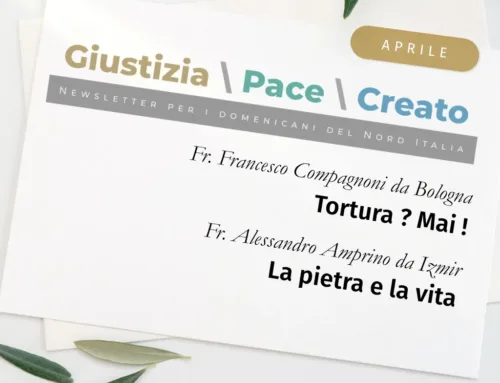Come la terra umile e disinteressata
1 settembre 2019
Letture: Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
L’umiltà è forse la più controversa, incompresa e decisiva delle virtù raccomandate dalla Scrittura e lungo tutta la tradizione ecclesiale a coloro che intendono seguire il Signore. Umiltà deriva da humus, che in latino significa “terra”, e richiama ad un tempo “lo stare sotto” e “la fertilità disinteressata”. È a questo che ci richiama la pagina tratta dal vangelo secondo Luca, che tiene insieme – così com’è proclamata nell’odierna Liturgia della Parola – una parabola sulla scelta dell’ultimo posto e una parabola che invita ad offrire un banchetto per coloro che non hanno da ricambiare. Nell’umile generosità che non guarda al proprio interesse immediato, come la terra che tutti sostiene pur essendo calpestata, i cristiani sono chiamati a sorreggere la vita buona nella storia.
La prima delle due parabole evangeliche proposte viene introdotta da una riflessione sapienziale sul valore dell’umiltà tratta dal libro del Siracide. Che cosa comporta l’umiltà secondo il sapiente israelita? Innanzitutto porta l’uomo a compiere le proprie azioni con mitezza. Soprattutto coloro che sono ritenuti grandi, quanto più si comportano con umiltà, tanto più si dispongono ad ottenere la benevolenza del Signore. Orgoglio e superbia costituiscono degli ostacoli che impediscono di addentrarsi nella rivelazione dei segreti di Dio. Se solo gli umili lo glorificano è perché essi conoscono la potenza del Signore, in quanto lo hanno lasciato agire, senza ostacolarne la rivelazione dell’autentica potenza divina. Il saggio desidera un orecchio attento, perché l’orecchio è l’organo della rivelazione biblica che si attua precisamente nell’ascolto della Parola, cui segue la meditazione dell’insegnamento formulato in parabole. Ma non c’è alcun rimedio per la misera condizione del superbo, di colui che si compiace solo di se stesso, perché “in lui è radicata la pianta del male”. Che cosa può essere questa pianta del male? Con buona approssimazione possiamo dire che quest’espressione simbolica intenda indicare l’autosufficienza dell’uomo che giunge a diffidare di Dio stesso e a confidare solo in se stesso. Questo passaggio, letto alla luce della tradizione, possiede poi un’ampia potenzialità di senso quanto all’inquadramento della dottrina della grazia. Come hanno sottolineato, tra gli altri, i mistici renani come Meister Eckhart e Giovanni Taulero quanto più l’anima si radica nella condizione di umile abbandono, disponendosi ad una piena ricettività, tanto più Dio si dispone ad essere ospitato dall’anima nelle persone del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La presenza di Dio per grazia nell’anima del giusto coincide infatti con quella che la teologia chiama inabitazione trinitaria. In questo senso, se la fede è da considerarsi come quella peculiare partecipazione alla conoscenza che Dio ha di se stesso, donata all’uomo come sviluppo operativo del dono della grazia santificante, allora risulta teologicamente più chiaro che cosa significa che “ai miti Dio rivela i suoi segreti”. Resi partecipi della vita divina, gli umili conoscono infine la potenza di Dio perché ne vivono e quindi riescono a riconoscerla negli eventi della storia e nelle vite degli altri.
La parabola di Gesù, al di là delle massime del sapiente, ma anche delle speculazioni teologiche, va direttamente al nucleo della questione. Poiché Gesù sta per pranzare nella casa di uno dei capi dei farisei si può supporre che l’evento narrato nel breve racconto parabolico abbia tratto l’ispirazione dalla situazione in cui si trovava lo stesso Gesù. Ai farisei che lo osservano, il Signore ricorda che “chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato” e lo fa raccontando dell’invitato che invece di porsi al primo posto, a motivo dell’alta considerazione che ha di sé, per poi essere costretto ad occupare l’ultimo, si pone direttamente all’ultimo posto, ottenendo un cortese invito ad avanzare di posizione. Chi si vuole promuovere da sé ha tutto da perdere, mentre chi si accontenta sinceramente dell’ultimo posto ha tutto da guadagnare.
Ma l’umiltà non è tutto, anzi sant’Agostino dice: dove c’è la carità, c’è l’umiltà (ubi caritas, ibi humilitas). La seconda parabola, rivolta al capo dei farisei che aveva invitato Gesù, lo richiama ad invitare a pranzo o a cena non coloro che – in qualità di amici o parenti – possono ricambiarne il gesto, ma “poveri, storpi, zoppi, ciechi”. Non potendo questi ultimi ricambiare l’invito, aiuteranno colui che ha offerto loro il pasto a gioire nel dare, più che nel ricevere, facendogli così scoprire la beatitudine. Come è riportato negli Atti degli Apostoli, Gesù ha infatti detto che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Colui che dona senza guardare al proprio tornaconto, scopre così quella gioia che fa tutt’uno con lo stato di beatitudine. La logica del dono tuttavia non esclude il ritorno in senso assoluto. Il Signore sa che per la creatura anche il dono di carità va ad inserirsi all’interno di un quadro ispirato allo scambio, per rispettare l’intenzione fondamentale tesa a custodire il primato della relazione interpersonale. In questo senso, la parabola invita ad attendersi solo la ricompensa pensata da Dio per la risurrezione dei giusti alla fine dei tempi.
Improntato alla medesima attenzione per i legami interpersonali, il passo della Lettera gli Ebrei ci ricorda l’orizzonte della ricompensa finale stessa: “voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova”.
[/fusion_text][/one_full]]]>