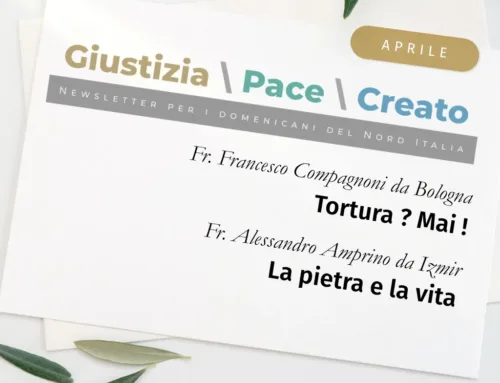Traduzione delle prime pagine del “Saint Dominique” (1926) di George Bernanos
Se si interroga per la prima volta la vita di un santo, in modo particolare quella di un fondatore di un ordine religioso, le voci che ne escono sembrano dapprima innumerevoli e diverse al punto di turbare lo spirito. Questa specie di vertigine non farà che crescere se ci si applica a seguire passo dopo passo l’ordine dei fatti, perché la loro successione non ci insegna alcunché, o ben poca cosa. Questi grandi destini, più di tutti gli altri, sfuggono a qualunque determinismo: irradiano, risplendono di una stupefacente libertà.
Ad un primo esame, soltanto il genio sembra dare a certe vite eccezionali questo carattere di indipendenza, di sovrana spontaneità. Ma non è così. Si potrebbe al contrario sostenere – e grazie a quali illustri esempi! – che il genio porta sempre con sé qualcosa di ostile e di irriducibile, come un principio di sterilità. Se realizza quella meraviglia di ispirazione e di equilibrio che è l’opera d’arte compiuta, è il più delle volte, e quando la carità divina non vi collabora, per una specie di specializzazione mostruosa che esaurisce tutte le potenze dell’anima e la lascia divorata d’orgoglio in un egoismo inumano. L’uomo di genio è così poco dentro la sua opera che questa è quasi sempre una testimonianza impietosa contro di lui. Invece l’opera del santo è la sua stessa vita, egli è tutto intero nella sua vita.
Ma comunque la difficoltà non è superata: al contrario, a questo punto della riflessione sembra insormontabile. L’esperienza degli uomini ci insegna a penetrare molto avanti nelle loro intenzioni mediante la sola comparazione – fin troppo crudele – di pubblico e di privato. Nessun atteggiamento così bene e pazientemente custodito che non porti in sé le proprie contraddizioni, nessuna bugia così compatta che non abbia le sue brecce, o che almeno non possa essere vista al contrario. Come il chirurgo impara la vita sopra il morto, come il biologo analizza gli scarti organici per cercare di sorprendervi il segreto degli scambi e delle funzioni, il moralista sa che ha davanti a sé questo personaggio di artificio e di inganno, questo cadavere camuffato da cui noi stessi siamo così spesso ingannati più degli altri, fino a che il primo sguardo del giudice, al di là della morte, lo faccia andare in frantumi. Ma il santo è di fronte a noi quello che sarà di fronte al giudice. Tocchiamo qui, con sguardo stupefatto, non una vita diminuita (come si vorrebbe far credere), in cui la mortificazione sottrae incessantemente, bensì la vita nella sua effusione e come allo stato nascente, la vita stessa, come a una fonte ritrovata. Ritrovata perché l’avevamo perduta e, una volta ritrovata la perdiamo nuovamente. Il povero nomade, nel cuore del suo deserto di sabbia, abituato a disputare al terreno, per sé e per le sue bestie, un sottile filo d’acqua torbida, fa fatica a credere che c’è sempre un paese di fontane e che ci sarà ancora per le sue labbra e per le sue mani questo spruzzo gelato, questo zampillio pieno di schiuma e d’azzurro.
Si pensa che un Benedetto, un Domenico, un Ignazio ci siano più vicini di Giovanni della Croce o di Caterina da Siena, perché sono anche dei legislatori e dei conquistatori. È vero che così ci danno delle lezioni che la prudenza umana può capire. Ma come è corta questa visuale! L’ambizioso che sognasse di trovare qui un metodo e delle ricette originali perderebbe il suo tempo. La santità non ha formule, o, per meglio dire, le ha tutte. Riunisce ed esalta tutte le potenze, realizza la concentrazione orizzontale delle più alte facoltà dell’uomo. Semplicemente per riconoscerla, esige da noi uno sforzo e la partecipazione, in qualche misura, al suo ritmo, al suo immenso slancio. Senza dubbio sembra più facile trascrivere, secondo il vocabolario comune, la storia della fondazione dei frati Predicatori piuttosto che una illuminazione di Angela da Foligno ma tuttavia, se fosse in nostro potere alzare sulle opere di Dio uno sguardo unico e puro, l’ordine dei Predicatori ci apparirebbe come la carità stessa di san Domenico realizzata nello spazio e nel tempo, come la sua preghiera visibile.
Ecco perché i moderni metodi della critica storica, in queste materie, non finiscono di deluderci. Le vite che sono guidate dalle grandi passioni umane, al di là del loro apparente disordine, hanno una certa rozza unità che permette di trasportare i più illustri sul piano delle vite ordinarie, di trovarvi ,se si può dire così, un qualche denominatore comune. Niente di più monotono della passione, che si ripete così miseramente. Cesare ci fa comprendere l’ambizioso politico e quel tal funzionario ci fa intravvedere l’animo di Nerone. La passione prende tutto ciò che le si dà e non restituisce nulla. Al contrario la carità dona tutto e le è reso ancora di più. Quale contabilità sovrumana può rendere conto di questo magnifico scambio? Se lo storico si attiene a una rigorosa esattezza, ci farà capire poche cose dell’esistenza di un santo. Le vecchie leggende dicono molto di più, perché trascrivono in simboli delle realtà profonde. Hanno quel carattere di ingenuità che sembra fatto apposta per scombinare la nostra logica e la nostra esperienza. Come non potrebbero avere questa caratteristica? Ogni vita di santo è come una nuova fioritura, l’effusione, in un mondo reso dall’eredità del peccato schiavo dei suoi morti, di una miracolosa, edenica ingenuità.
In questo senso ci importa poco che Domenico appartenesse o no all’illustre famiglia dei Guzman e che cos’ fosse parente degli antichi re di Spagna. Ci basta sapere che aveva sangue di militari e immaginarlo bambino, con i lunghi capelli biondi, quasi rossi, gli occhi azzurri e la pelle bianca dei suoi avi visigoti, Ruodrico, Wilhem o Froila, sulla cima dell’umile torre signorile di Caleruega, l’unico “torreon” rettangolare edificato da suo nonno alla frontiera del paese moro, mentre fissa le acque pallide del Douro mentre scivolano verso il mare. All’estremo orizzonte (…) la sierra di Guadarrama leva al cielo i suoi alti contrafforti scuri, e dietro la loro enorme massa c’è Toledo, dove i capi castigliani lottano contro i Mori. In una tappa o due, aperta la breccia, i piccoli cavalli instancabili sarebbero sulla sponda del fiume e si vedrebbero nuovamente agitarsi sulle rive i lunghi mantelli bianchi e gli usberghi dorati … Non è così lontano il tempo in cui nei mercati mori si poteva avere una donna per un dirhem e un fanciullo cristiano per mezzo dirhem! (…)Diventare schiavi dei Mori fu una delle piaghe della Spagna, più angosciante che la carestia. Ora, mentre questi duri contadini o i nobili così simili a loro, sognavano di rappresaglie, di armate sconfitte e di teste tagliate, non è lecito supporre che il piccolo Domenico, che fino alla morte fu un amico così tenero, sentisse a questi racconti il suoi cuore fremere di pietà? Teodorico d’Apolda ci riporta che, vent’anni dopo, il giovane canonica di Osma decise un giorno di vendersi come schiavo per riscattare il figlio di una povera donna. Forse tocchiamo qui la molla segreta di un’infanzia di cui i cronisti ci dicono ben poco. Questa delicata immaginazione fu presto crudelmente ferita. Molti altri giovani Castigliani subirono negli stessi anni la stessa prova, e ne uscirono induriti. Ma invece Domenico si apre d’istinto e interamente alla divina compassione – e da qui, senza dubbio, comincia il poema della sua carità.