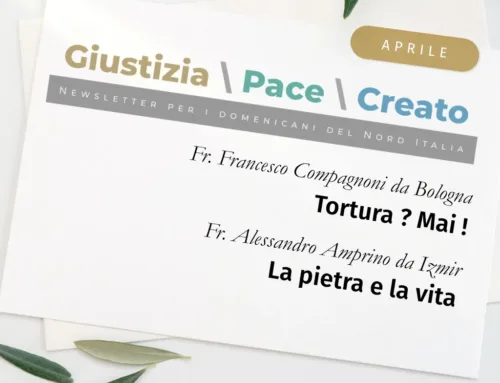Il recente dibattito tra virologi, epidemiologi e clinici, allestito dal circo mediatico sulla persistenza del Covid-19, più che informare sull’intensità della carica virale, sembra piuttosto aver intensificato il disorientamento di molti cittadini incapaci di discernere a quale esperto affidarsi per valutare lo stato della pandemia. Tale spettacolarizzazione, conseguente all’inedito ruolo pubblico assunto dai “virologi” nel contesto dell’emergenza, ha poi finito per favorire il moltiplicarsi delle opinioni pressoché da parte di chiunque e soprattutto la loro strumentalizzazione politica, con esiti prossimi quantomeno al genere tragicomico. Nonostante queste ed altre derive, ritengo che il dibattito in questione costituisca un valido esempio di quella postverità con cui – secondo alcuni critici – ci confrontiamo in Occidente almeno dagli anni Ottanta del Novecento. Secondo la definizione degli Oxford Dictionaries, i cui curatori l’hanno eletta a parola dell’anno nel 2016, dicendo “postverità” ci si riferisce ad una serie di circostanze in cui «i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l’opinione pubblica del ricorso all’emozione e alle convinzioni personali».
Diffusosi esponenzialmente per caratterizzare la bizzarra modalità comunicativa di Donald Trump o per motivare il fenomeno Brexit, il termine “postverità” indica una situazione che non può essere, a mio avviso, appiattita sul piano delle più banali fake news o sbrigativamente derubricata come superfluo sociologismo. Secondo Anna Maria Lorusso, professoressa di semiotica presso l’Università di Bologna, la postverità è l’esito di una complessa interazione tra i mezzi di comunicazione di massa e i loro utenti, per cui – soprattutto attraverso le dinamiche instaurate dai social media– si è giunti ad una situazione in cui «ciascuno pretende di dire il vero», per cui «si arriva al paradosso di mille verità diverse che sembrano equiprobabili». È in questo senso che, secondo Lorusso, «la postverità non nega la verità. La moltiplica e la privatizza», in modo che «non si sente più la necessità di una legittimazione istituzionale» con grave danno per la tenuta del legame sociale (Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling, Laterza 2018). Poiché il popolo di Dio, radunato dal Cristo e incamminato verso la Gerusalemme celeste, vive nella storia e nella società non è affatto fuori luogo chiedersi in che modo il fenomeno della postverità si ritrovi anche nella Chiesa.Si pensi, in primo luogo, ai ripetuti attacchi rivolti a papa Francesco da sedicenti giornalisti o all’infamante dossier pubblicato dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò nell’agosto del 2018. Per quanto puntualmente decostruita da Lo scisma americano. Come l’America vuole cambiare papa di Nicolas Senèze (Mondadori, 2020), quella campagna denigratoria può continuare ad echeggiare tra le righe dei giornali anche perché i limiti di quanto può venir pubblicamente asserito sono determinati da un contesto postveritativo. Non potendo verificare come le cose stiano effettivamente, il lettore – che ha smarrito gran parte della fiducia nell’istituzione – finisce così per affidarsi ad una o all’altra delle narrazioni messe sulla piazza mediatica in base alle emozioni suscitate o alle convinzioni previamente elaborate, eleggendola a verità.
Chi intendesse screditare l’attuale pontificato, dovrebbe quindi solamente limitarsi a perseverare nel proprio storytelling per ottenere il consenso di coloro che – nell’odierna e disdicevole estetizzazione del ruolo del Papa – non condividono “a pelle” le scelte di Vescovo di Roma. Qual è l’effetto della moltiplicazione mediatica delle “verità” su papa Francesco? Lungi dal contribuire alla conoscenza di quanto accade nella Chiesa, quest’atomizzazione non mira forse solamente a frammentare il mondo cattolico? Un secondo esempio può essere tratto dal volume curato da R. Bichi e P. Bignardi dal titolo Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia (Vita e Pensiero, 2015). Pubblicato per commentare una ricerca condotta dall’Istituto Toniolo su un campione di centocinquanta giovani mette in luce, tra i diversi aspetti positivi, la tendenza ad una radicata privatizzazione della verità della fede, perlopiù declinata attraverso la semantica degli affetti e dimentica di ogni riferimento ecclesiale. Percepita come una dimensione intimistica, la fede viene comunicata attraverso riformulazioni personali che manifestano non solo l’evidente individualismo, ma anche l’appartenenza di quei vissuti all’orizzonte postveritativo in quanto autentici ed isolati ad un tempo, e pertanto fragili e potenzialmente inefficaci rispetto alle sfide della secolarizzazione o anche solo della vita stessa.
Non c’è infatti bisogno di scomodare san Tommaso d’Aquino per comprendere quanto una fede che vacilli sul senso della verità, anche per il solo fatto che Gesù dichiara di essere “la” verità (cfr. Gv 14,6), trovi non poche difficoltà ad esercitare l’affidamento che la caratterizza. È per questo che nel tempo della postverità occorre non cedere di un centimetro – nella predicazione e nella catechesi, ma anche nell’esercizio della vita cristiana – sulla verità che è Cristo e sulla qualità affettiva che sant’Agostino chiamava gaudium de Veritate. Laddove il mondo tende a moltiplicare i frammenti veritativi, assolutizzando la fragile ed aggressiva micro-verità di ciascuno, il vangelo ci dona invece la possibilità di accogliere l’umile e mite verità che salva unendo nella carità. Per quanto nell’orizzonte postveritativo la narrazione e l’affidabilità vengono considerate come caratteristiche intrinseche al darsi della verità, togliendo qualche ostacolo ideologico all’annuncio evangelico, è tempo di un’intensificazione qualitativa dell’esercizio della caritas veritatis che metta in contatto con l’indefettibile affidabilità della Verità crocifissa e risorta.
fra Marco Salvioli(“Nostro Tempo”, 12 luglio 2020)
[/fusion_text][/one_full]]]>