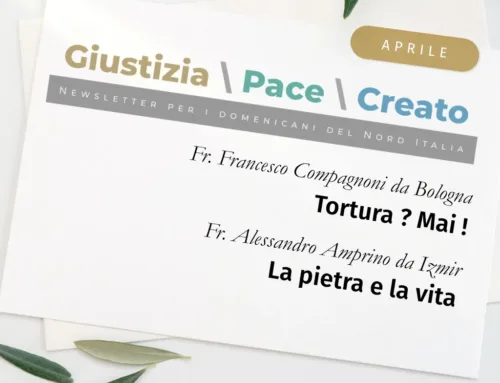Fabio Bodi, artista, insegnante, scrittore, genitore e scout ci parla della sua esperienza pluridecennale di laico domenicano a partire da una serata di preghiera con le nostre monache di Moncalieri.

Nella vita domenicana la comunità è il luogo della misericordia, della consolazione, della gioia. Lo è in modo teorico, normativo e tal volta lo è davvero. La condizione umana a cui siamo soggetti ci obbliga però a partire dalla nostra solitudine, dal fondo. Perché c’è una solitudine nella vita, una solitudine dovuta all’incapacità di sentire le presenze.

In questo contesto è difficile dire quale sia la specifica solitudine della religiosità laicale. Qui l’incontro con i confratelli non è che un episodio in una vita spesa nella “valle di Elah”. Eppure, in questo saliente della predicazione così oscuro, ho presente momenti di conforto fraterno, di incontro; momenti di calore intenso. Sono “stazioni”, fermate in una corsa che ogni giorno attraversa le vie del mondo.

Fra Enrico mi ha chiesto di scrivere qualche riga sulla vita della fraternita e vorrei cominciare da una di queste “stazioni”. Nella prima Chiesa le “stazioni” erano ritrovi occasionali, estemporanei e a volte persino casuali che avvenivano ai crocicchi, nei locali pubblici, nelle piazze.

La “stazione” era un tempo rubato al lavoro, al padrone, al riposo. Era tempo per la preghiera, per la consolazione, tempo speso per la gioia di incrociare il fratello. È in questo sentimento che il 24 maggio ho preso la salita di santa Brigida e sono entrato nel cortile del monastero, giusto in tempo per i vespri. È stata una “stazione”, un tempo di consolazione, di condivisione. Vedere i frati, le monache, i confratelli laici, le suore, tutti riuniti nella cappella di Santa Maria di Magdala è stato un piacere fisico, una vera consolazione che forse dovremo dichiarare senza pudore.

C’è un tempo breve che è quello bello, quello del piacere, della pienezza, dell’attendere che è proprio dell’incontro fraterno. Ci sono uomini e donne che al mattino offrono la loro prima parola a Dio. Fratelli che come me chiedono al Signore di dischiudere le labbra per poter proclamare la lode. Ci sono, ma non li vedo, so che esistono e che la mia non è una lode solitaria.

Qui li incontro. Io non lo so come sarà la luce della resurrezione, ma se chiudo gli occhi e provo a ricordare i vespri di Santa Magda percepisco una piccola luce fatta di sorrisi, di mani incontrate in “stazione”. Enrico mi chiede di dire qualcosa di tutto questo, dovrei rispondergli che non c’è nulla da dire perché ci stringiamo, sì proprio così, ci facciamo vicini.
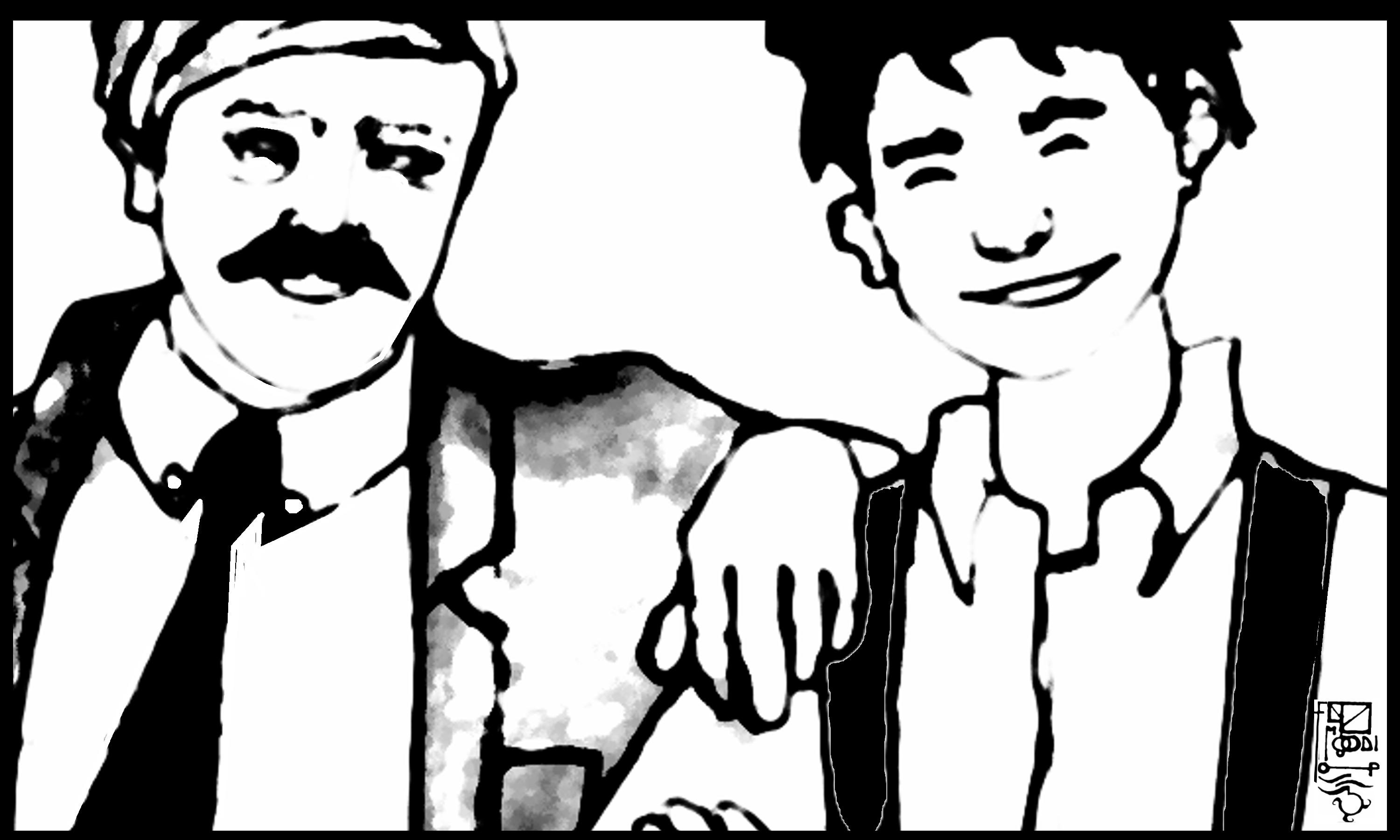
Mangiamo, beviamo e chiacchieriamo scioccamente come pulcini nel pollaio, ma non facciamo nulla di più che guardare le nostre facce ordinarie, che celebrare la normalità di una vita che vorremmo spesa alla santa predicazione. Se dovessimo tenere un diario della vita laicale fermandoci a questi momenti, alle riunioni di fraternita, rischieremo di fare un cronicon del nulla, ripetitivo fino alla noia.

Di fatto non è qui la vita del laico. La vita nella religiosità laicale è consacrata nella sua indole secolare, nella spiritualità del lavoro, della domus. Se dovessi rendere ragione della vita laicale dovrei raccontare tante singole vite: quella di Adriano che la scuola l’ha fatta ai “grandi motori”, alla catena di montaggio.

Dovrei parlare di Domenico torturato su un letto d’ospedale con il rosario in mano, del signor Grillo che non sa parlare e lava il pavimento della chiesa, perché questa è la sua Santa Predicazione. Dovrei parlare di vite da eremo, da cenobio, di solitari o di famiglie. Vite sulla linea del fuoco o nel ritiro della senilità, vite normali, offerte, per quel poco che valgono, all’ordine della predicazione.

Io in queste stazioni arrivo in moto, altri come me entrano con le due ruote e la madre priora mi grida di lasciarle le chiavi perché poi va lei a fare un giro. Qualcuno è già seduto in coro, ma posso baciare la mia ragazza di ottant’anni, suor Margherita, l’amore segreto della mia vita. Non so se ci siano donne più belle, forse anche noi siamo belli.

Non so se meritiamo questa gioia pacata, questo profumo di glicine a maggio. Il frate musicista si rifiuta di cantare, “ne ho da basta”, dice, qualcuno ride, qualcuno brontola e nella stanza entra la luce del vespero. A volte sento la bellezza, qualcosa che vuole farmi sapere che non c’è motivo di avere paura.

Dopo, quando tutti se ne sono andati mi fermo, parliamo del Viet Nam, di una monaca conosciuta al capitolo, di una chiesa che non conosce crisi di vocazione, che sa dov’è il fronte, che non conosce demarcazione di ceto perché frati e monache, laici e suore conoscono lo stesso lavoro, la stessa fabbrica, il medesimo falansterio e magari anche la stessa galera.

Parliamo della nuova casa, la mia nuova casa, il loro nuovo monastero. La mie consorelle hanno cucinato, ho stappato delle bottiglie e insieme ad un altro motard, non abbiamo mollato il vassoio delle fragole annegate nel cioccolato. Sono sazio, allegro e mi sento stupido mentre scendo verso la città. Stupido come un ventenne perché ormai è la terza volta che compio vent’anni e questa è la mia quarta vita. Stupido perché non so cosa mi accadrà, dove andrò, cosa farò.
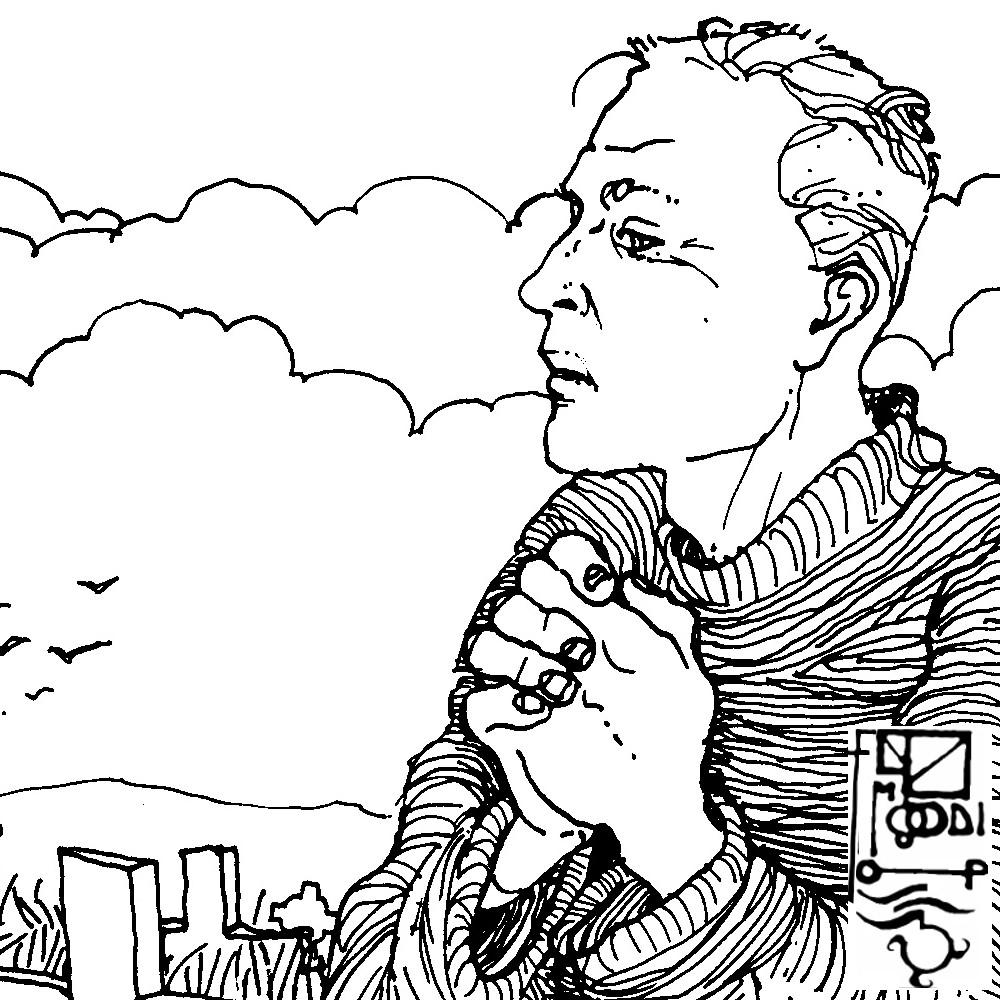
Mi alzerò alle cinque e trenta, sistemerò qualcosa e dirò le lodi. Il momento più bello del giorno, il meno compromesso, il più intimo. Nessuno mi telefona, nessuno mi vede e nemmeno so se servirà a qualcosa questa liturgia nascosta, ma voglio perderlo tutto questo tempo.

Voglio ricordare tutti: Giuseppe, quattro isolati più avanti fa lo stesso, Berth forse prega in francese o in mòoré, Franco fa il turno di notte. Non ho scelto nessuno di loro, li ho trovati. Dicono che Dio non scelga i migliori, ma renda migliori quelli che sceglie. Non so, io non so niente e vi racconto il poco che c’è da raccontare: il sorriso, la mano, il tempo regalato, rubato, assassinato. Dio è grande! Noi siamo nulla ed è sul nulla che godo di voi, di questi momenti: nulla da dire, poco da raccontare, te lo mando per quello che è, poca roba, di gente da niente.

Una cosa sento di dirla perché è su questo poco, su questo resto che sento il regno, il saliente delle predicazione, la veglia d’armi, dell’attesa: dell’attendere come un aspettare e dell’attendere come curare.

L’imminenza non è che un gioco, un restare sospesi in un atto di fiducia come quello dei bambini nella mani del padre. Loro lo sanno che per nulla al mondo papà ti lascerà cadere e chiudono gli occhi in una certezza che non ha motivo, ragione, buon senso e volano.

Ecco cosa fanno i laici della predicazione, tengono accesi piccoli fuochi, luci che non si vedono durante il giorno, ma che con l’avanzare della notte rischieranno di essere la sola traccia verso il cielo.